Nella città moderna, e soprattutto nelle periferie novecentesche, il cortile è il luogo dei giochi e delle confidenze, dei segreti e delle confessioni, della gioia e della paura. I ragazzini si ritrovavano a giocare a pallone e le donne passavano il tempo a chiacchierare o a stendere la biancheria. La letteratura è piena di riferimenti alla vita che si svolge negli spazi chiusi delimitati dai caseggiati popolari. A Brooklyn, Napoli o Roma i cortili si popolano di storie. In questo secondo post vi proponiamo una selezione dei brani, letti in occasione di una passeggiata tra i lotti della Garbatella il 9 novembre 2019, il cui protagonista o la cui scenografia è appunto il cortile.
![Lotto della Garbatella [Foto: Associazione culturale GoTellGo, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2020/04/Garbatella_Cortili_2019_06.jpg)
Due giorni fa è venuto a mancare un importante filosofo italiano, Remo Bodei, punto di riferimento per la filosofia italiana e occidentale. L’Italia ha dato nel Novecento filosofi strepitosi, a volte più conosciuti all’estero che nel loro paese, basti pensare a Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Franco Rella o Carlo Sini. Non siete dei filosofi? Non importa, leggeteli come se i loro testi fossero dei racconti. Filosofia come letteratura.
Oggi tenteremo di utilizzare ciò che Remo Bodei chiamava “la geometria delle passioni” per mettere in relazione spazio e letteratura.
Partiamo mettendoci d’accordo sullo spazio del nostro gioco: il cortile. Avviciniamoci a questa parola a partire dalla sua etimologia. Ricordatevi che la ricerca etimologica non riguarda esclusivamente filologi e linguisti ma è anche una chiave della memoria storica di ognuno di noi.
Vediamo cosa dice il dizionario etimologico:
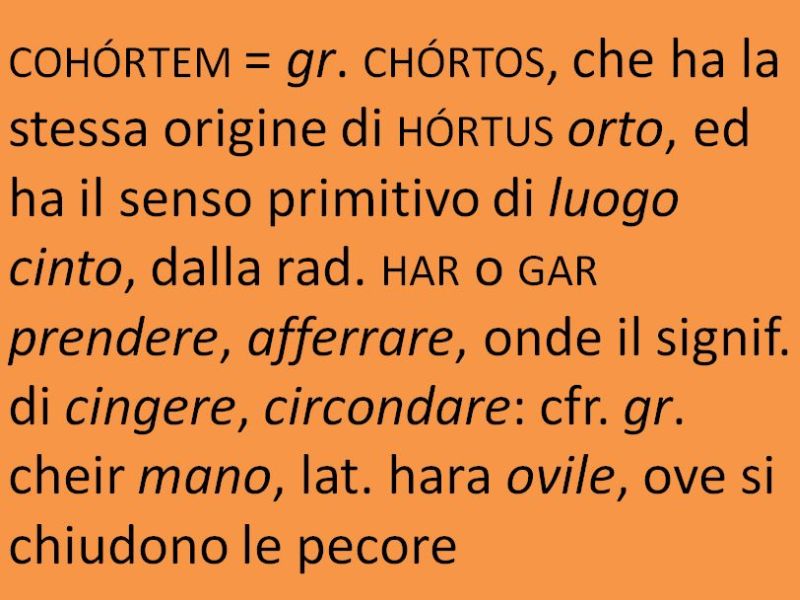
Quindi «cortile» proviene dal latino Cohórtem e dal greco Chórtos, e condivide l’origine con Hórtus, un luogo cinto che ha dei limiti, delle frontiere, dei confini determinati. Inoltre, il cortile ha qualcosa in comune con le parole prendere, afferrare, cingere, circondare.
Cortile: i latini chiamavano così il recinto per le pecore, nonché lo spazio in mezzo al caseggiato della colonia, dove era custodito tutto ciò che serviva per nutrirsi. Nel Medioevo questa voce si allargò per indicare tutto il recinto, che comprendeva case, orti e altri spazi di una villa. Pian piano il cortile si arrogò il compito di rappresentare un territorio intero; giunse anche a insediarsi fra la gente d’armi, nei palazzi di giustizia e perfino nelle regge. Diventò metafora delle persone che costituivano la casa del principe, o di chi era al suo seguito, per guadagnare il suo affetto: così si iniziò a “far la corte” a qualcuno…
Palazzeschi Aldo (1909), La fontana malata, in Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 2002.
Clof, clop, cloch,
cloffete
cloppete
clocchete
chchch…
È giù
nel cortile,
la povera
fontana
malata;
che spasimo!
sentirla tossire….
Leopardi Giacomo (1898), Zibaldone di pensieri, Torino, Einaudi, 1977.
Era la luna nel cortile, un lato
Tutto ne illuminava, e discendea
Sopra il contigui lato obliquo un raggio…
Nella (dalla) maestra via s’udia un carro
Del passegger, che stritolando i sassi,
Mandava un suon, cui precedea da lungi
Il tintinnio dei mobili sonagli.
Simukka Salla (2013), Rosso il Sangue, Milano, Mondadori, 2014.
[…] Dal cortile della scuola elementare si udivano i richiami, le risate e le grida dei bambini. Lumikki li osservò mentre correvano, saltavano, andavano in altalena e si arrampicavano, con il fiato che si condensava e le guance arrossate dal freddo. Negli ingombranti vestiti imbottiti sembravano paffuti pupazzi di neve variopinti. Con lo sguardo tentò di individuare i bambini, soli, emarginati dagli altri, che se ne stavano ai limiti del cortile. Tese l’orecchio per distinguere tra le grida quelle che non nascevano dalla gioia, ma dalla paura. Lumikki sapeva che per alcuni il cortile della scuola non è un parco giochi che brilla al sole delle giornate invernali, ma rappresenta il regno del terrore, in cui le giornate sono lunghe e nere come la notte. Una bambina girava da sola intorno all’edificio della scuola in stile liberty, color giallo paglierino. Camminava a testa bassa, il passo lento. Lumikki si soffermò brevemente sull’incedere della piccola. Si voltava a ogni angolo per guardarsi le spalle? Sussultava troppo spesso? Nel suo sguardo si era insediata l’angoscia? […] In quel preciso istante si rese conto che qualcosa non andava. Qualcuno non doveva trovarsi lì. […] Ma era troppo tardi. […]
McCleen Grace (2012), Il posto dei miracoli, Torino, Einaudi, 2013.
[…] Se guardi la terra da giù sembra molto grossa. Sei nel cortile della scuola e ti abbassi e metti la faccia giù come quando cerchi qualcosa di piccolo e sembra ancora più grossa. Ci sono chilometri di cemento che vanno in là e chilometri di cielo che vanno in su e nel mezzo chilometri di niente che non vanno da nessuna parte. I bambini che giocano a calcio sono giganti, la palla è un pianeta, le bambine che saltano la corda sono alberi che si sradicano. e a ogni giro della corda il terreno trema. Ma se dal cielo guardi verso il basso i bambini e le bambine e la palla e la corda sembrano più piccoli di mosche. […]
Per riflettere: Torniamo alla geometria delle passioni. Bodei mette in dubbio l’apparente ovvietà della correlazione passione-ragione e spezza una lancia a favore della prima. Perché non pensare le emozioni, i sentimenti e i desideri non come «alterazioni» di un presupposto stato non perturbato dell’animo, ma come stati «costitutivi della tonalità di qualsiasi modo di essere psichico»? Le passioni si rivelano così «sensate», ombra o specchio di una ragione, a sua volta «appassionata».
Abbiamo letto frammenti che hanno a che vedere con il cortile della scuola: meravigliosa palestra per andare oltre una geometria cartesiana con un dentro e un fuori, con l’inclusione e l’esclusione, con la dolcezza e la crudeltà.
Nella letteratura, almeno nei brani che abbiamo scelto, il cortile può essere uno spazio chiuso senza porte e finestre, una rigida scacchiera ma anche una sfera bucherellata, nella quale entrano e dalla quale escono passioni e ragioni, entrambe al plurale.
![Lotto della Garbatella [Foto: Associazione culturale GoTellGo, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2020/04/Garbatella_Cortili_2019_04.jpg)
[…] L’unica finestra della cameretta dà su un cortile; non, però, sul cortile principale del casamento, vasto e chiassoso, ma su una stretta corte secondaria, per dove non passa quasi nessuno. Il casamento s’innalza per dieci piani, e in questa corte, chiusa fra quattro altissimi muri di cemento, come una sorte di torre scoperta in cima, il sole non entra mai, per nessuna ora o stagione; sul suolo, fra le pietre sparse d’immondizie, punta un’erba scolorita.
Oltre alla mia, s’affacciano sulla corte poche e rade finestre, donde s’ode il canto malinconico di qualche povera serva di paese che si sporge talora a battere un tappeto, e, la domenica, appende un suo piccolo specchio all’impannata per mirarsi mentre s’acconcia i capelli. Un verdone in gabbia, ospite d’una casa senza sole, viene talora esposto fuor del davanzale all’aria della corte, sulla cui cima scoperchiata, e quasi vertiginosa, s’incrociano rondini stridenti. [… ] e davvero, oggi, mi par l’effetto d’una stregoneria la velocità del tempo che ho vissuto qui rinchiusa: tre lustri interi son corsi via con un moto così rapido che, a ripensarli, mi sembrano un unico giorno. Anzi, un’ora ferma di pomeriggio estivo, nella luce senza sole che fuori è bianca, riverberando sui muri di calce del cortile; e dentro, riflessa dal colore del parato, ha un cupo tono elettrico. […]
Perec Georges (1978), La vita istruzioni per l’uso, Milano, Rizzoli, 1984.
[…] La signora Albin è una di quelle donne alte, secche e ossute, che sembrano uscite da Ces dames aux chapeaux verts. Va ogni santo giorno al cimitero; esce di casa verso le due, prende l’84 a Courcelles, scende alla Gare d’Orsay, prende il treno Juvisy-sur-Orge, e rientra in rue Simon-Crubellier verso le sei e mezzo sette; a parte questo se ne sta chiusa in camera sua.
Tiene l’alloggio in modo perfetto: le piccole piastrelle del pavimento sono scrupolosamente lucide e a quelli che vanno a trovarla chiede di camminare su pattine tagliate nella tela di sacco; le due poltrone sono coperte di fodere di nylon.
Sulla tavola, il camino e i due tavolinetti, qualche oggetto ravvolto in vecchi numeri dell’unico giornale che legga con piacere, il France-Dimanche. È un grande onore essere ammessi a guardali; non li spacchetta mai tutti insieme, e raramente più di due o tre per una data persona. A Valène, per esempio, ha fatto ammirare una scacchiera di mogano con intarsi di madreperla, e un rebab, violino arabo a due corde, che pare risalga al XVI secolo; alla signorina Crespi ha mostrato – senza spiegarne la provenienza né la possibile relazione con il suo soggiorno in Siria – una stampa erotica cinese raffigurante una donna supina onorata da sei piccolo gnomi dai volti rugosi; a Jane Sutton, che non le piace perché inglese, ha fatto vedere solo quattro cartoline anch’esse senza rapporti apparenti con la sua biografia: un combattimento di galli nel Borneo, dei Samoiedi imbacuccati che attraversano sulle loro slitte trainate da renne un deserto di neve nel Nord asiatico; una giovane donna marocchina, vestita di seta a righe, chiusa in un’armatura di catenelle, anelli e paillette, il petto rigonfio mezzo nudo, le narici dilatate, gli occhi pieni di una vita animale, che ride a tutti denti; e un contadino greco con una specie di berrettone, una camicia rossa e un panciotto grigio che spinge l’aratro. Ma alla signora Orlovska che, come lei, ha vissuto nell’Islam, ha mostrato quanto aveva di più prezioso; una lampada di rame traforata con piccoli ricami ovali che formano fiori di favola, proveniente dalla moschea degli Omayyadi dov’è sepolto Saladino, e una foto colorata a mano del Gran Hôtel distrutto: un grande cortile quadrato, circondato su tre lati da fabbricati dipinti di bianco con grandi fasce orizzontali rosse, verdi, azzurre, nere; un enorme ciuffo di oleandri i cui fiori tutti sbocciati mettono macchie rosse nel verde delle foglie; in mezzo al cortile, sul pavimento di marmo colorato, zampetta una piccola gazzella con zoccoli sottili e occhi neri.
La signora Albin comincia a perdere la memoria e forse anche un po’ la ragione; gli inquilini del piano se ne sono resi conto quando una sera si è messa a bussare alle loro porte per metterli in guardia da pericoli invisibili, che chiamava blouson noir, oppure harkis, e talvolta perfino OAS; un’altra volta, ha cominciato ad aprire uno dei suoi pacchetti per farlo vedere a Smautf, e Smautf si è accorto che aveva incartato come se fosse uno dei ricordi più preziosi una lattina di succo d’arancia. Una mattina, qualche mese fa, ha dimenticato di mettersi la dentiera che tutte le notti immerge in un bicchiere d’acqua, dopo di che non l’ha rimessa più; la dentiera si trova nel suo bicchiere sopra il comodino, coperta da una specie di muschio acquatico dal quale a volte spuntano piccoli fiori gialli. […]
Per riflettere: «[…] non, però, sul cortile principale del casamento», dice la Morante, «ma su una stretta corte secondaria». Qui abbiamo una geometria che implica delle gerarchie. Ci stanno spazi più piccoli per alcuni e più grandi per altri. Non è un modo di escludere o di discriminare. È una distribuzione dei rapporti sociali nei luoghi, talvolta solo una percezione di essi. Con la Morante vediamo che quello spazio enorme che avevamo prima, il cortile della scuola, inizia a frammentarsi.
[Mentre leggiamo, una persona si affaccia a spolverare, urla, chiama qualcuno…. Questo sono i cortili. Una voce che accende una linea di comunicazione che si trasforma in eco tra i palazzi].
![Lotto della Garbatella [Foto: Associazione culturale GoTellGo, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2020/04/Garbatella_Cortili_2019_03.jpg)
Charrière Henri (1969), Papillon, Milano, CDE, 1970.
[…] il cortile dove passiamo lunghe ore a camminare in fila. Un dué! Un, dué! Un, dué!… Camminiamo a gruppo di centocinquanta detenuti! La coda di serpente è lunga, gli zoccoli sbattono. Silenzio assoluto obbligatorio. Poi viene il «Rompete le file!». Tutti si siedono per terra, si formano dei gruppi, a seconda delle categorie sociali. Prima di tutto gli uomini della vera malavita, tra i quali interessa poco l’origine: corsi, marsigliesi, tolosani, bretoni, parigini ecc. C’è anche uno dell’Ardèche, sono io. E a favore dell’Ardèche devo dire che, in questo convoglio di millenovecento uomini, ce ne sono due soltanto: una guardia campestre che ha ucciso la moglie e io. Conclusione: quelli dell’Ardèche sono brave persone.
Un pomeriggio ero seduto al sole quando mi si avvicina un tale. Ha gli occhiali, è piccolo, magro. […]
«Sei tu Papillon?». Ha un fortissimo accento corso.
«Sì, sono io. Cosa vuoi da me?».
«Vieni al cesso» mi dice e se ne va. […]
Mi dirigo verso i gabinetti situati in mezzo al cortile e là faccio finta di orinare. […]
Senza guardarmi mi dice: «Sono il cognato di Pascal Marra. Al parlatorio mi ha detto che se avevo bisogno di aiuto potevo rivolgermi a te da parte sua».
«Sì, Pascal è amico mio». Cosa vuoi?
«Non posso più portare il bossolo; ho la dissenteria. Non so con chi confidarmi e ho paura che me lo rubino o che lo trovino i secondini. Ti supplico Papillon, portalo qualche giorno per me».
E mi mostra un bossolo molto più grosso del mio. Ho paura che mi tiri una trappola e che me lo chieda per sapere se ne ho uno: lo saprà se gli dico che non sono sicuro di poterne portare due. Quindi, freddamente, gli chiedo:
«Quanto c’è dentro?».
«Venticinquemila franchi».
Prendo senz’altro il bossolo, d’altronde molto pulito, e davanti a lui me lo introduco nell’ano chiedendomi se un uomo può portarne due. Non lo so. Mi alzo, mi rimetto i calzoni… va tutto bene, non sento niente.
«Mi chiamo Ignace Galgani» mi dice prima di andarsene. «Grazie, Papillon».
Sciascia Leonardo, Gli zii di Sicilia, Torino, Einaudi, 1962.
Filippo era già da un pezzo che si godeva nel cortile della caserma la consegna delle armi. Mio padre andò via e restai anch’io a guardare, era come una processione, appena fatta la consegna i contadini uscivano esplodendo di bestemmie «i ladri ora hanno le mitragliatrici e le persone oneste manco lo schioppo a bacchetta» dicevano; ed era vero, c’erano ladri in giro, due trovati col moschetto e la maschera furono paternamente assolti dal maggiore americano, un uomo tutto bianco e dritto, dicevano al suo paese insegnasse filosofia, forse dicevano così perché qui tutto ciò che appare strambo vien fatto scaturire da filosofia. Il maggiore mandò assolti i due ladri, raccomandò loro vita quieta ed onesta, il lavoro; l’interprete traduceva con una faccia che voleva dire «non ci capisco niente, vedete che fessi sono gli americani» e poi l’avvocato difensore, che non era riuscito a piazzare una parola, imprecò persino contro Colombo, così assolti era difficile che quei due sganciassero qualche centinaio di lire. A noi il maggiore americano piaceva, gli andavamo dietro per le sale del municipio e mai che ci dicesse di andar via, ogni tanto ci guardava e diceva con stento «piccoli siciliani». Doveva essere un buon uomo, forse aveva bambini in America, a casa sua. Anche il soldato che stava a guardare la consegna dei fucili aveva una faccia buona, masticava gomma e sorrideva; scambiava qualche parola col brigadiere e poi restava silenzioso a sorridere e masticare. Forse pensava casa sua, l’America tutta di case alte e automobili, e sua madre che guardava da una finestra alta. Non sembrava accorgersi di noi; quando si mosse per porgerci le tavolette di gomma da masticare credemmo volesse mandarci via, invece ci diede le tavolette e disse «è buona, non è menta» certo a lui la menta non piaceva, neanche a me piaceva. Dissi «grazie» e anche Filippo, con gli estranei riuscivamo a passare per ragazzi educati, sapevamo anche fare i sanluigi, ma questo atteggiamento lo sparagnavamo per l’ora della dottrina cristiana. L’americano ci guardava sorridendo. […] Sul cortile il cielo era come l’acqua quando vi si scioglie il turchinetto per il bucato, c’erano nuvole come schiuma; e il campanile d’arenaria della chiesa di San Giuseppe pareva d’oro. «Vieni con me?» disse il brigadiere. Il soldato se ne andò senza salutarci.
Ci tornammo l’indomani nel cortile della caserma; il soldato sedeva allo stesso posto, leggeva un libro e masticava. Quando ci vide disse «alò» e si rimise a leggere. Dopo un po’ chiuse il libro, tirò fuori il pacchetto della gomma e ci offrì le tavolette. «Ciunga» disse «così si chiama».
«E le caramelle come si chiamano?» domandò Filippo.
«Chendi si chiamano» disse «ci sono chendi di tutte le specie in America».
«Qui» io dissi «non ci sono chendi».
«Nemmeno patate ci sono» disse Filippo «io mi sono scordato che gusto hanno le patate, quando ero piccolo sempre le mangiavo».
«Le patate» io dissi «c’è una guardia municipale che di nascosto le vende; le vende care, mio padre dice che conviene comprare carne».
«Sì» disse Filippo «la carne: non c’è pane e vuoi trovare la carne».
«Perché non portate il frumento?» domandai all’americano «mio padre dice che lo buttate a mare il frumento».
«Non è vero che lo buttiamo a mare» disse «non abbiamo navi per portarlo; quando finisci la guerra porteremo il frumento».
Per riflettere: Parliamo del cortile del carcere. Abbiamo visto cortili urbani di libero accesso e cortili con un accesso ristretto, quelli delle scuole. La geometria di questi cortili è rigida, uno schema fatto di mattoni, di ringhiere, di corridoi, di mura. Quella delle passioni può essere rigida, cartesiana, ma può essere non euclidea, iperbolica, anche nell’angusto cortile del carcere o nel cortile della caserma, spazi rigidamente codificati.
Primo spunto di storia di famiglia: mio nonno paterno, tedesco, alla fine della guerra cadde prigioniero dei francesi e stette tre anni in un campo di prigionia. Un uomo di due metri e cinque, che quando fu liberato pesava quarantacinque chili. Una delle poche cose che raccontava del periodo di prigionia era la perdita di un anello di famiglia che, come Ignace e Papillon, aveva nascosto nel corpo. Anche lui ebbe un problema di dissenteria e raccontava di aver cucito il gioiello all’interno dell’orlo del suo cappotto. Se questo fosse stato il racconto di un film hollywoodiano, il trucco di mio nonno avrebbe avuto successo e l’anello sarebbe rimasto nella mia famiglia; però, siccome non lo è, vi confermo che il cappotto gli fu tolto e che l’anello andò perso.
Secondo spunto di storia di famiglia: Sciascia raccontava dei «ciunga» e dei «chendi» degli americani in Sicilia. Qualcosa di simile accadeva con gli americani oltre il nord dell’Italia. Mentre mio nonno era prigioniero in Francia, mio padre, classe ‘38, era in un paesino nella frontiera tra la Germania e l’Austria. Ricordava che quando arrivarono gli americani si portarono via tutto ciò che c’era nella loro casa; però addolcirono lo svaligiare con barrette di «ciocleit». Noi, abituati a poter mangiare merendine quando vogliamo, non possiamo capire la gioia di uno dei cosiddetti “Kriegskinder” (bambini di guerra) per un pezzo di cioccolata che si scioglie in bocca.
![Lotto della Garbatella [Foto: Associazione culturale GoTellGo, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2020/04/Garbatella_Cortili_2019_02.jpg)
Arrivati a Senjan, gli uccelli volavano per un po’ in cerchio sopra la città, facendo un gran baccano, poi si posavano sul tetto della moschea. Il vecchio corvo, appollaiato sulla cupola, teneva d’occhio la situazione. […] Tutti sapevano che gli uccelli migratori trovavano grano e acqua sul tetto della moschea, ma nessuno sapeva che Faqri Sadat metteva le trappole. […] Appena gli uccelli arrivarono sotto i cesti, Faqri Sadat tirò le cordicelle, i cesti caddero e gli uccelli rimasero prigionieri. A quel punto le nonne uscirono in cortile. […] Golabe aprì il coperchio del cesto, tirò fuori un uccello e lo consegnò a Faqri Sadat. Faqri Sadat studiò le penne dell’uccello. Ne avevano catturato sette nuove specie. Le nonne li rinchiusero in sette gabbie diverse e li portarono nello studio di Aga Jan.
Quella sera, quando tornò a casa, Aga Jan andò direttamente nel suo studio, dove lo aspettava Faqri Sadat.
«Com’è andata la giornata?» Avete catturato qualche uccello particolare? «Gli uccelli sono bellissimi» rispose Faqri, «oggi ne abbiamo già guardati molti da vicino». […]
Golbanu tirò fuori dalla gabbia uno degli uccelli e gli coprì la testa con un cappuccio, perché non si spaventasse alla luce violenta della lampada e cercasse di stare tranquillo sul tavolo. […]
«Questo ha delle penne bellissime, ma non eccezionali, purtroppo», disse alla fine, mostrando il disegno a Faqri Sadat con la punta della matita. […]
«I colori sono diversi, ma il disegno non mi è nuovo», disse Golbanu, Presero l’uccello dalle mani di Aga Jan, lo rinchiusero in gabbia e ne tirarono fuori un altro.
«Oh, questo ha un piumaggio magnifico, vedete questi piccoli motivi, qui, sulla punta? Sono delle righine rosse e verdi intrecciate. Credo proprio che i nostri disegnatori ne ricaveranno qualcosa».
Faqri Sadat studiò le penne con la lente d’ingrandimento: «Hai ragione, sono molto originali e la loro lucentezza le rende ancora più belle. Com’è possibile che ogni uccello abbia penne completamente diverse dagli altri? Sono tutti disegni unici. […]
Le nonne passarono all’esemplare successivo. […]«Com’è forte questo!» esclamò Golabe. «Guardate, ha le penne più grosse di tutti.
«Hai ragione, è davvero straordinario» osservò Golbanu, «Ha delle macchie azzurre che brillano come pietre preziose». «E’ un capolavoro» esclamò Aga Jan. «Da dove può venire tanta bellezza?».
Faqri Sadat prese la matita […] e iniziò a copiare i piccoli disegni delle penne. Non si rendevano conto di essere degli artisti. Pensavano solo di portare avanto con il loro lavoro la tradizione della casa, una tradizione che riguardava i tappeti e il bazar. Volevano produrre i tappeti più belli del paese, anzi, di tutto il Medio Oriente.[…]«Non oso ancora esprimere la mia gioia» disse Aga Jan, «ma penso che qui abbiamo davvero qualcosa».
Al mattino presto, quando la luce del giorno entrava in casa, le nonne, dopo aver spazzato il cortile, portavano gli uccelli alla howz. Davano loro da mangiare e li facevano bere nella vasca. Poi li baciavano sulla testa e li lanciavano di nuovo in aria. Gli uccelli facevano mezzo giro sopra la moschea e partivano verso sud. Riprendevano il volo a tappe forzate per raggiungere i loro compagni. Se volavano senza sosta, verso sera sarebbero arrivati in vista del Golfo Persico, dove faceva caldo e i grandi squali si spostavano come strane barche nell’acqua.
Lapierre Dominique, La città della gioia, Milano, Mondadori, 1985.
«Grande fratello Paul, ti abbiamo trovato una camera nel nostro cortile» annunciò Shanta con voce fremente. «Nessuno ci vuole abitare perché l’inquilino precedente si è impiccato». […]
Una camera in uno di quei cortiletti dove si ammucchiava un centinaio di persone, dove si nasceva e si moriva insieme, dove si tossiva, si sputava, si urinava, si defecava, si piangeva insieme, dove ci si amava, ci s’insultava, ci si picchiava, ci si odiava insieme. Era da un pezzo che Lambert aveva voglia di abbandonare il relativo anonimato della sua viuzza per vivere in un cortile, per fondersi anche più totalmente con gli altri.
Ashish e Shanta avevano organizzato tutto. Rispettando le usanze, presentarono il loro protetto al decano del cortile. […] Krishna Jado viveva da ventisette anni a Anand Nagar. […] L’accoglienza fu dovunque calorosa. Come diceva Shanta: «Un father sahib è Babbo Natale che ti piove addosso».
Undici famiglie, più o meno ottanta persone, vivevano in quel rettangolo di circa dodici metri per otto. Erano tutte indù. Gente di diversa religione doveva evitare di coabitare, secondo la norma, in uno stesso gruppo di abitazioni perché la minima differenza nelle consuetudini vi assumeva proporzioni esorbitanti. […]
Ogni giorno, ogni ora, offrivano il pretesto per qualche festa o celebrazione. Un giorno erano le prime mestruazioni di una ragazzina celebrate in pompa magna con canti e danze, e con l’esibizione del pannolino che aveva assorbito il primo sangue. Un altro, tutte le ragazze da marito rendevano un culto al lingam del dio Shiva per chiedergli un marito buono quanto lui. Un’altra volta, una futura madre celebrava il primo mese di gravidanza. Oppure una puja grandiosa, con bramino, musici e banchetto, glorificava l’istante in cui un bambino riceveva dalle mani del padre il primo boccone di riso.
La cerimonia, che era al culmine quando Lambert giunse al suo nuovo domicilio, non era una delle meno sorprendenti. Radunate dietro il pozzo, una quindicina di donne cantava a squarciagola dei cantici. Davanti a loro c’erano piatti di offerte: mucchietti di chicchi di riso, banane, petali di fiori, bastoncini d’incenso. Il decano del cortile spiegò che stavano implorando Sitola perché salvasse la piccola Onima. La bambina aveva la varicella e Sitola è la dea del vaiolo. Tutti gli abitanti del cortile partecipavano alla puja. Dopo un digiuno di tre giorni, non avrebbero mangiato né uova né carne – ammesso che ne avessero avuti i mezzi – né nessun altro alimento che non fosse bollito, finché la bambina non fosse guarita. Nessuna donna avrebbe potuto lavare o stendere la biancheria per non irritare la divinità.
García Márquez Gabriel, Occhi di cane azzurro, Milano, Oscar Mondadori, 1998.
Uscimmo nel cortile, tutt’e tre, senza parlare; forse credevamo di avere pensieri comuni. Forse pensavamo che non sarebbe stata la cosa migliore accendere le luci della casa. Lei desiderava rimanere sola – forse –, seduta nell’angolo scuro, annodandosi l’ultima treccia, che sembrava essere l’unica cosa che sarebbe sopravvissuta al sua transito verso la bestia.
Fuori, nel cortile, immersi nel profondo respiro degli insetti, ci sedemmo a pensare a lei. L’avevamo fatto altre volte. Potevamo dire che stavamo facendo quello che avevamo fatto tutti i giorni delle nostre vite.
Tuttavia, quella sera era diverso: lei aveva detto che non avrebbe più sorriso, e noi, che la conoscevamo bene, avevamo la certezza che l’incubo era divenuto verità. Seduti in un triangolo, la immaginavamo là dentro, assorta, inabile, anche ad ascoltare gli innumerevoli orologi che segnavano il ritmo, marcato e minuzioso, con cui stava tramutandosi in polvere: «Se almeno avessimo il coraggio di desiderare la sua morte» pensavamo in coro. Ma la volevamo così: brutta e glaciale, come un meschino contributo ai nostri occulti difetti. […]
Non ci eravamo stupiti un mattino, dopo esserci svegliati, quando l’avevamo trovata in cortile distesa sul ventre, a mordere la terra in un duro gesto estatico. Allora aveva sorriso, si era rigirata a guardarci; era caduta dalla finestra del secondo piano sulla dura argilla del cortile, ed era rimasta lì, tesa e concreta, con la bocca sul fango umido. Ma avevamo poi saputo che l’unica cosa che serbava intatta era la paura delle distanze, il naturale terrore dinanzi al vuoto. […] Aveva detto che non sapeva come fosse arrivata nel cortile. Aveva detto che aveva sentito molto caldo, che aveva udito un grillo penetrante, acuto che sembrava – così aveva detto – volesse demolire la parete della sua stanza, e che lei si era messa a ricordare le orazioni della domenica, con la guancia pigiata contro il suolo di cemento.
Per riflettere: Inseriamo ora nel nostro gioco le idee di un altro filosofo del Novecento: Gilles Deleuze e i suoi concetti di “spazio liscio” e “spazio striato”. Lo spazio liscio dei deserti, delle steppe, dei mari; lo spazio striato delle strade che dividono, segmentano, codificano. In Mille piani Deleuze spiega: «Lo spazio liscio e lo spazio striato […] non sono della stessa natura. Ma a volte possiamo notare un’opposizione semplice tra i due tipi di spazio. Altre volte dobbiamo indicare una differenza molto più complessa, per cui i termini successivi delle opposizioni considerate non coincidono del tutto. Altre volte ancora dobbiamo ricordare che i due spazi esistono in realtà solamente per i loro incroci reciproci: lo spazio liscio non cessa di essere tradotto, intersecato in uno spazio striato; lo spazio striato è costantemente trasferito restituito a uno spazio liscio».
Le descrizioni dei brani che stiamo leggendo creano strie, sottili righe, nello spazio liscio del cortile. Possiamo ora pensare a questi testi come a una cartografia che rappresenta la geometria delle passioni, dei sentimenti, delle ragioni.
![Gabriela e Maria Teresa guidano la passeggiata letteraria alla Garbatella [Foto: Associazione culturale GoTellGo, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2020/04/Garbatella_Cortili_2019_01.jpg)
I bambini indietreggiavano in fretta per farla passare, così che il suo procedere sull’asfalto del cortile era simile al passaggio di Mosè attraverso il Mar Rosso, quando le acque si divisero. Era davvero formidabile, con il camiciotto stretto in vita dall’alta cintura, e i pantaloni verdi alla zuava. I polpacci fasciati dagli aderenti calzettoni sembravano pompelmi. «Amanda Trippi!» sbraitava. «Tu, Amanda Trippi, vieni fuori!».
«Reggetevi forte» sussurrò Ortensia.
«Che succede? » chiese Violetta a voce bassa.
«Quella cretina di Amanda» disse Ortensia, «durante le vacanze si è lasciata crescere i capelli e sua madre le ha fatto le trecce. Una vera fesseria».
«Perché? » chiese Matilde.
«Se c’è una cosa che la Spezzindue non sopporta, sono le trecce» spiegò Ortensia. […] La Spezzindue aveva ormai raggiunto la sua vittima e torreggiava su di lei. «Voglio che quando tornerai a scuola, domattina, quelle trecce siano sparite!» abbaiò. «Tagliale e buttale nella spazzatura! Hai capito?».
Amanda, sebbene paralizzata dalla paura, riuscì a balbettare: «P-p-ppiacciono tanto alla m-m-m-mia mamma. M-m-me le rifà ogni mattina!».
«La tua mamma è un’idiota!» tuonò la Spezzindue. […]
«La m-m-m-mia mamma mi trova molto carina così, signorina Spezzindue.
«Non me ne importa un fico secco di quel che pensa tua madre! ruggì la Spezzindue, e con una mossa brusca afferrò le trecce di Amanda con la destra, sollevandola da terra. Poi cominciò a farla roteare sempre più in fretta, mentre la bambina strillava a più non posso. […] La Spezzindue si chinò all’indietro per bilanciare il peso della ragazzina roteante, e prese a piroettare con abilità sulla punta dei piedi; in breve Amanda Trippi venne fatta girare così rapidamente che non la si vedeva più e a un tratto, con un urlo bestiale, la Spezzindue mollò le trecce e la bambina fu proiettata oltre la rete metallica del cortile.
[Amanda atterrò] con una lunga e aggraziata parabola sul campo da gioco [oltre il cortile]. Atterrò sull’erba e prima di fermarsi rimbalzò tre volte. Poi, sorprendentemente, si mise a sedere. Aveva l’aria stordita […], ma dopo un paio di minuti si alzò e trotterellò di nuovo verso il cortile. La Spezzindue si stropicciò le mani: «Niente male» grugnì, «se si pensa che sono fuori allenamento. Proprio niente male». Poi se ne andò a grandi passi.
Per riflettere: In questo caso il cortile compare come uno spazio intermedio tra la casa e il mondo. Una palestra dove allenarsi, ma dalla quale c’è poi bisogno di uscire, così come dalla casa. Scappare per salvarsi.
Levi Lia, Il segreto della casa sul cortile. Roma 1943-1944, Milano, Mondadori, 2001, p. 6 e ss.
Un giorno, all’ora di pranzo, Ludovico Segre disse una frase che avrebbe cambiato di colpo la vita della sua famiglia.
«Credo che sia proprio arrivato il momento di nasconderci da qualche parte».
Lo disse con voce apparentemente tranquilla, perché Ludovico amava molto l’umorismo […], quindi non era certo il tipo da fare una scena drammatica.
Ma tranquillo non era. […] A Roma erano entrati i tedeschi e tutto faceva pensare che tra poco avrebbero incominciato la caccia agli ebrei, com’era già successo negli altri paesi dell’Europa occupati dalla Germania. […] Loro erano ebrei. Il problema era tutto qui. […]
Ludovico era assolutamente deciso a organizzare la fuga, e dentro di sé era serissimo. […]
Io andrei in cima a una montagna dove non passa mai nessuno o in una campagna sperduta con dei boschi vicino» suggerirono le stelle a [sua figlia] Piera.
All’improvviso [Ludovico] si alzò e, come sovrappensiero, prese un foglio da disegno, tratteggiò una montagna con rocce e cespugli e poi ci piazzò in cima una pallina rossa. Dopo allungò la mano verso un altro foglio e cominciò a riempirlo di case, piazze e chiese. La pallina rossa comparve anche lì, ma così mescolata a tante palline di tutti i colori che quasi si faceva fatica a trovarla.
«In quale di questi due disegni si vede di più la pallina rossa?».
E così Ludovico, convinto dalle sue stesse parole, annunciò alla mamma e a Piera che sì, era il caso di scappare perché con i tedeschi in casa si trovavano in mortale pericolo, ma senza bisogno di fuggire lontano.
«Ci sposteremo in un quartiere dall’altra parte della nostra stessa città. Cercheremo una zona piena di persone, un palazzone con tanta gente che sale e scende per scale diverse, e ci mischieremo con loro, come questa pallina rossa con le altre palline.
«Ma come faremo a trovare questo quartiere lontano e con tante case come dici tu?».
«Nel palazzo che ho trovato… che è così,…» e la matita scivolava veloce, «credo che ci abitino più di mille persone, come in un intero paese. Non si tratta di un edificio singolo, Ma di quattro collegati tra loro, che si affacciano su un grande cortile quadrato. In ognuno di questi edifici ci sono quattro diverse scale e niente ascensori, perciò di gente che passa il tempo a salire e scendere ce ne deve essere un bel po’, più che alla stazione. Se ci faremo i fatti nostri e non parleremo con nessuno, nessuno si accorgerà di noi».
Deledda Grazia, Canne al vento, Milano, Treves, 1913.
[…] Tutti gli anni la primavera le dava questo senso d’inquietudine: i sogni della vita rifiorivano in lei, come le rose fra le pietre dell’antico cimitero; ma ella capiva che era un periodo di crisi, un po’ di debolezza destinata a cessare coi primi calori estivi, e lasciava che la sua fantasia viaggiasse, spinta dalla stessa calma sonnolenta che stagnava attorno, sul cortile rosso di papaveri, sul Monte ombreggiato dal passaggio di qualche nuvola, sull’intero villaggio metà dei cui abitanti era alla festa.
Eccola dunque col pensiero laggiù.
Le par d’essere ancora fanciulla, arrampicata sul belvedere del prete, in una sera di maggio. Una grande luna di rame sorge dal mare, e tutto il mondo pare d’oro e di perla. La fisarmonica riempie coi suoi gridi lamentosi il cortile illuminato da un fuoco d’alaterni il cui chiarore rossastro fa spiccare sul grigio del muro la figura svelta e bruna del suonatore, i visi violacei delle donne e dei ragazzi che ballano il ballo sardo. Le ombre si muovono fantastiche sull’erba calpestata e sui muri della chiesa; brillano i bottoni d’oro, i galloni argentei dei costumi, i tasti della fisarmonica: il resto si perde nella penombra perlacea della notte lunare. Noemi ricordava di non aver mai preso parte diretta alla festa, mentre le sorelle maggiori ridevano e si divertivano, e Lia accovacciata come una lepre in un angolo erboso del cortile forse fin da quel tempo meditava la fuga.
La festa durava nove giorni di cui gli ultimi tre diventavano un ballo tondo continuo accompagnato da suoni e canti: Noemi stava sempre sul belvedere, tra gli avanzi del banchetto; intorno a lei scintillavano le bottiglie vuote, i piatti rotti, qualche mela d’un verde ghiacciato, un vassoio e un cucchiaio dimenticati; anche le stelle oscillavano sopra il cortile come scosse dal ritmo della danza. No, ella non ballava, non rideva, ma le bastava veder la gente a divertirsi perché sperava di poter anche lei prender parte alla festa della vita.
Ma gli anni eran passati e la festa della vita s’era svolta lontana dal paesetto, e per poterne prender parte sua sorella Lia era fuggita da casa…. […]
Per riflettere: Linee di fuga che permettono di uscire da uno spazio la cui estrema codificazione rischia di annientare chi ci si trova dentro. Letteralmente.
Sepúlveda Luis, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Firenze, Salani, 1996.
[…] Alla luce della luna Segretario, Diderot, Colonnello e Zorba scavarono una buca ai piedi dell’ippocastano. Poco prima, badando che nessun umano li vedesse, avevano gettato la gabbiana morta dal balcone nel cortile interno. La depositarono in fretta nella fossa e la coprirono di terra. Poi Colonnello miagolò in tono grave.
«Compagni gatti, in questa notte di luna ci congediamo dai resti di una sfortunata gabbiana della quale non abbiamo mai saputo nemmeno il nome. L’unica cosa che abbiamo saputo di lei, grazie alle conoscenze del compagno Diderot, è che apparteneva alla specie dei gabbiani argentati e che forse veniva da molto lontano, dalla regione in cui il fiume si getta nel mare. Sappiamo pochissimo di lei, ma l’importante è che sia arrivata moribonda fino alla casa di Zorba, uno dei nostri, e che abbia riposto in lui tutta la sua fiducia. Zorba ha promesso di prendersi cura dell’uovo che lei ha deposto prima di morire, del piccolo che nascerà, e la cosa più difficile di tutte, compagni, ha promesso di insegnargli a volare… […]».
Ai piedi del vecchio ippocastano [nel cortile], i quattro gatti iniziarono a miagolare una triste litania, e ai loro miagolii si aggiunsero ben presto quelli dei gatti nelle vicinanze, e poi quelli dei gatti dell’altra riva del fiume, e ai miagolii dei gatti fecero coro gli ululati dei cani, lo straziante cinguettio dei canarini in gabbia, il garrito delle rondini nei loro nidi, il triste gracidio delle rane, e perfino le grida stonate dello scimpanzé Mattia. Le luci di tutte le case di Amburgo si accesero, e quella notte tutti gli abitanti si chiesero le ragioni della strana tristezza che improvvisamente si era impadronita degli animali. […]
Rodari Gianni, Brif bruf braf, in Favole al telefono, Torino, Einaudi, 1962.
Due bambini nella pace del cortile, giocavano a inventare una lingua speciale per poter parlare tra loro senza far capire nulla agli altri.
«Brif braf», disse il primo.
«Braf brof» rispose il secondo. E scoppiarono a ridere.
Su un balcone del primo piano c’era un vecchio buon signore a leggere il giornale, e affacciata alla finestra dirimpetto c’era una vecchia signora né buona né cattiva.
[mentre leggiamo un signore si affaccia alla finestra e ascolta anche lui il brano e le nostre chiacchiere].
![Passeggiata letteraria tra i cortili della Garbatella [Foto: Associazione culturale GoTellGo, CC BY NC SA]](https://www.appasseggioblog.it/wp-content/uploads/2020/04/Garbatella_Cortili_2019_05.jpg)
«Come sono sciocchi quei bambini», disse la signora.
Ma il buon signore non era d’accordo: «Io non trovo».
«Non mi dirà che ha capito quello che hanno detto».
«E invece ho capito tutto. Il primo ha detto: «che bella giornata». Il secondo ha risposto: «domani sarà ancora più bello».
La signora arricciò il naso ma stette zitta, perchè i bambini avevano ricominciato a parlare nella loro lingua.
«Maraschi, barabaschi, pippirimoschi», disse il primo.
«Bruf», rispose il secondo. E giù di nuovo a ridere tutti e due.
«Non mi dirà che ha capito anche adesso», esclamò indignata la vecchia signora.
«E invece ho capito tutto», rispose sorridendo il vecchio signore. Il primo ha detto: «come siamo contenti di essere al mondo». E il secondo ha risposto: «il mondo è bellissimo».
«Ma è poi bello davvero? » insisté la vecchia signora.
«Brif bruf braf» rispose il vecchio signore.
Trotsky Lev, Testamento politico del 27 febbraio 1940, in La vita è bella, Milano, Chiarelettere, 2015.
Natascia si è appena avvicinata alla finestra che dà sul cortile, e l’ha aperta in modo che l’aria entri più liberamente nella mia stanza. Posso vedere la lucida striscia verde dell’erba ai piedi del muro, e il limpido cielo azzurro al disopra del muro. La vita è bella. Invito le generazioni future a purificarla da ogni male, oppressione e violenza e a goderla a pieno.
Per riflettere: Trotsky dice che la vita è bella. Rodari dice che il mondo è bello. Un vecchio gesuita mi raccontò una volta un aneddoto: Trotsky era in Messico, in esilio, e voleva farsi fare un tavolo da lavoro. Sembra, diceva il gesuita, che fosse stato proprio Diego Rivera a indicargli un suo falegname di fiducia. Dato che c’erano alcuni problemi di lingua, Trotsky fece il disegno di un tavolo molto semplice e indicò al falegname di farlo così, proprio così, come nel disegno.
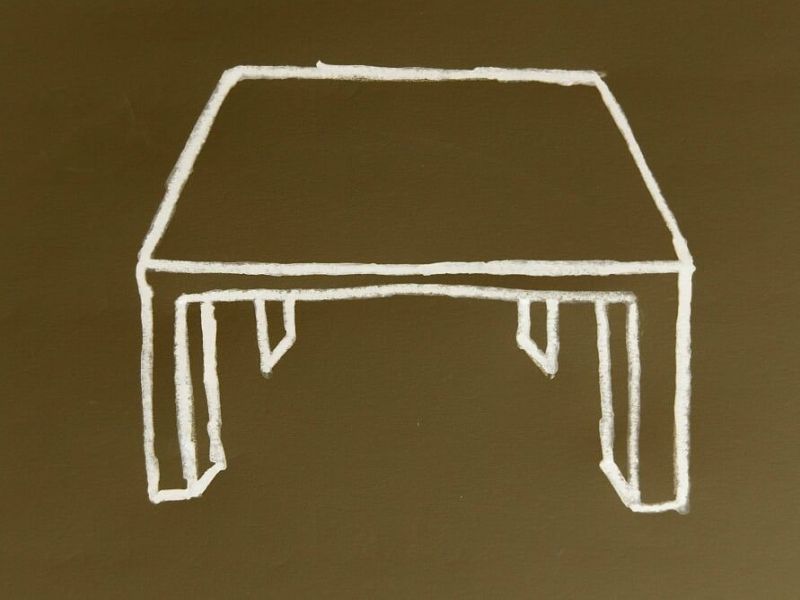
Ribadì che lo voleva proprio in quel modo, sebbene il falegname lo guardasse sorpreso e chiedesse ulteriori conferme.
Quando il politico russo ricevette il tavolo rimasse sorpreso. Il tavolo era esattamente come lo aveva disegnato: con un piano inclinato e con due zampe più lunghe delle altre. Certe convenzioni geometriche non sono condivise.
[a cura di Gabriela Häbich, in collaborazione con Maria Teresa Natale]
Passeggiata realizzata nell’ambito del progetto “Labirinti di parole” nel Municipio Roma VIII”
LEGGI ANCHE:
Letteratura e cortili: passeggiata letteraria tra i cortili della Garbatella